
Riccardo Patrese al GP di San Marino nel 1990
Quali sono stati i piloti italiani più forti di tutti i tempi? Senza nulla togliere al grandissimo Fisichella, assente in questa classifica, ecco la nostra top five:
Nino Farina
Gli anni Cinquanta furono anni importantissimi per l’automobilismo italiano, segnati da grandi vittorie e anche grandi lutti. La prima generazione dei campioni che aveva combattuto nelle epiche sfide anteguerra, guidata da quel Tazio Nuvolari che scomparve per un ictus proprio nel 1953, aveva ceduto il posto a un gruppo di nuovi piloti, in parte cresciuti in quelle stesse gare – dalla Mille Miglia ai primi Gran Premi – e in parte emersa dopo la fine del conflitto. All’inaugurazione del Campionato mondiale di Formula 1, nel 1950, si presentava così una pattuglia di piloti italiani ben agguerrita: per l’Alfa Romeo correvano Giuseppe Farina, Luigi Fagioli, Piero Taruffi e Consalvo Sanesi, ai quali si deve aggiungere l’argentino, ma figlio di italiani, Juan Manuel Fangio, forse il più talentuoso pilota di tutti i tempi; per la Maserati c’era Franco Rol, per la Achille Varzi c’era Nello Pagani, per la Milano c’erano Felice Bonetto e Franco Comotti mentre Clemente Biondetti correva per conto proprio; infine, ovviamente, ai nastri di partenza c’era pure la Ferrari con Luigi Villoresi, Alberto Ascari e Dorino Serafini. Il campionato lo vinse Nino Farina, un pilota che aveva già 44 anni e una solida esperienza alle spalle: alla Mille Miglia era arrivato secondo nel ’36, nel ’37 e nel ’40, prima che la Seconda guerra mondiale bloccasse tutto, segnalandosi comunque in tutte le gare disponibili all’epoca. Con l’Alfa aveva un lungo e proficuo rapporto, rafforzato già all’esordio nel Mondiale grazie alla conquista, a Silverstone, della pole position, del Gran Premio e del giro più veloce della corsa; vinse poi anche in Svizzera e in Italia, diventando il primo campione del Mondo della categoria, davanti solo di tre punti al compagno di scuderia Fangio, che vinse lo stesso numero di Gran Premi ma fu costretto più spesso al ritiro (sorte che gli toccò anche nell’ultima gara, a Monza, quella decisiva). Farina corse anche nelle sei stagione successive, arrivando a concludere la sua carriera in Formula 1 a cinquant’anni suonati, incamerando ancora qualche vittoria e sfiorando nuovamente il titolo nel 1952, quando, passato alla Ferrari anche per il ritiro dell’Alfa, si piazzò dietro al dominatore assoluto di quegli anni, Alberto Ascari, del quale parleremo a breve. Il suo stile di guida era arrembante e sfacciato, espressione di un carattere altrettanto sfrontato che veniva messo in mostra anche dai rotocalchi dell’epoca, che sottolineavano la sua passione per le belle donne e il vezzo di correre con un sigaro cubano in bocca. Erano altri tempi, insomma, in cui il fascino personale del pilota superava di gran lunga la tecnologia delle automobili, ed in cui si rischiava veramente la vita ad ogni corsa. Una vita che comunque Farina avrebbe perso poco dopo il ritiro dalle corse: nel giugno del 1966, non ancora sessantenne, infatti prese a velocità troppo alta una curva nei pressi di Aiguebelle, in Francia, mentre si recava ad assistere al Gran Premio di Reims, finendo fuori strada e morendo a bordo della sua Ford Cortina Lotus.
Leggi anche:
Alberto Ascari
Nato a Milano nel 1918, essendo figlio d’arte aveva esordito già negli anni Trenta guidando soprattutto motociclette, tanto che nel ’38 era già stato messo sotto contratto dalla Bianchi, decidendo poi due anni dopo di passare alle quattro ruote, esordendo nel 1940 nella Mille Miglia. Passò la guerra a riparare veicoli militari e a rifornire di benzina l’esercito italiano in nord Africa, ma nel 1947 – grazie soprattutto alle insistenze di Gigi Villoresi, amico e socio d’affari nonché suo futuro compagno di squadra in Formula 1 – decise di tornare alle corse accettando un contratto con la Maserati. Già sul finire del decennio era ritenuto il principale antagonista di Nino Farina, pilota più navigato e maturo, e quando il Mondiale prese il via nel 1950 aveva ormai firmato per la Ferrari, casa in forte ascesa anche se per il momento lontana dalla forza dell’Alfa Romeo, che con la sua Alfa 158 stava dominando le corse a ruote scoperte. Fu così solo a partire dal 1951 che il pilota milanese iniziò ad avvicinarsi agli alfisti, prima vincendo i Gran Premi al Nürburgring e a Monza, poi conquistando nel 1952 un titolo che ha qualcosa di leggendario: facilitato dal ritiro dell’Alfa Romeo e dall’infortunio a Fangio, che non disputò alcuna gara nel Mondiale, Ascari vinse tutte le gare alle quali partecipò tranne quella di Indianapolis (nella quale era comunque l’unico pilota non americano e fu costretto al ritiro), facendo registrare un record. L’anno dopo Fangio ritornò – anche se per la Maserati e non per l’Alfa, che continuava a non partecipare – e provò a dar battaglia, ma Ascari trionfò in quattro dei primi sei GP della stagione e mise la vittoria in tasca, confermando anche quello che era il suo tipico stile di guida che lo vedeva scattare subito in testa nei primi giri, imponendo un alto ritmo alla corsa, salvo poi gestire il vantaggio accumulato. Nel 1954, ormai appagato dei successi con la Ferrari, firmò per la Lancia, che era quasi un’esordiente nel settore corse: si impose subito nella Mille Miglia, mentre per quanto riguarda la Formula 1 fu dato inizialmente in prestito alla Maserati, con la quale però fu vittima di due rotture che lo portarono al ritiro; fu poi prestato – mentre la Lancia affinava la propria vettura – alla stessa Ferrari, ma anche qui, pur lottando per la prima posizione a Monza, fu costretto al ritiro; infine esordì con la stessa Lancia, finalmente pronta, nell’ultimo GP della stagione, facendo registrare il giro più veloce ma anche qui non arrivando al traguardo. Nel 1955, infine, tutto sembrava finalmente pronto per far tornare Ascari a lottare per il titolo, visto anche che in alcune gare extracampionato la Lancia si era comportata ottimamente; la stagione però si rivelò subito sfortunata, prima, a Monaco, con una terribile uscita di strada a causa di una macchia d’olio che portò la vettura addirittura ad inabissarsi in mare, poi con l’incidente che costò la vita al pilota: quattro giorni dopo Monte Carlo, infatti, Ascari decise di raggiungere Villoresi ed altri amici a Monza, dove stavano testando una nuova Ferrari, la stessa auto che Ascari chiese di provare e che, capovolgendosi, finì per schiacciarlo al terzo giro di pista, procurandone la morte sul colpo. La Lancia decise, subito dopo quella morte, di cedere tutto il suo materiale alla Ferrari e ritirarsi dalle corse.
Riccardo Patrese
Dopo i fasti degli anni Cinquanta, per i tifosi italiani arrivarono anni di magra. Le scuderie della nostra penisola si ridussero progressivamente, fino a rimanere in corsa solo Maserati e Ferrari, con la prima relegata comunque a posizioni di rincalzo; soprattutto, mancavano i piloti tricolori che potessero lottare per il titolo: dopo il 1960 l’unico italiano che si avvicinò alla vetta della classifica finale fu Lorenzo Bandini, che nel ’64 arrivò quarto dietro a tre piloti britannici, tanto è vero che molti si consolarono tifando per Clay Regazzoni, svizzero di lingua italiana, secondo al Mondiale del ’74, o per l’italoamericano Mario Andretti, terzo nel 1977 e campione del Mondo nel 1978. Qualcosa iniziò a cambiare nei primissimi anni ’80, quando nella classifica finale cominciarono a emergere tre giovani piloti italiani, Elio De Angelis, Riccardo Patrese e Michele Alboreto, con il primo che proprio nel 1980 riusciva a salire sul podio a Interlagos e il secondo faceva lo stesso a Long Beach. Ma partiamo da Patrese, che, più vecchio di qualche anno, aveva esordito prima degli altri in Formula 1: padovano, classe 1954, Patrese arrivò nella massima categoria nel 1977, ad appena ventitré anni, dopo un ottimo percorso che dai kart l’aveva portato alla Formula 3, dove si era diplomato campione europeo. Dotato di un forte temperamento, aveva una guida molto aggressiva e sfrontata, che gli attirò simpatie tra i tifosi ma anche antipatie tra i colleghi; qualche anno fa, a tal proposito, ha fatto il giro del mondo il video, registrato all’interno di una Honda Civic, in cui si vedevano le reazioni esterrefatte della moglie Francesca Accordi portata da lui in giro lungo un circuito, senza tanti riguardi per la paura di lei e per le promesse fatte in precedenza. In Formula 1 arrivò grazie alla Shadow, team statunitense da poco attivo nella categoria da una costola del quale sarebbe nata poi la Arrows, seconda scuderia dello stesso Patrese. Proprio nella sua seconda stagione iniziarono ad arrivare i primi risultati, con un secondo posto in Svezia e un quarto a Montreal; dopo altri tre podi, la prima vittoria in un GP arrivò nel 1982 con il passaggio alla Brabham, quando sembrava finalmente arrivato l’anno giusto per il pilota padovano visto che vinse anche l’importante Gran Premio di Monaco (in una gara caratterizzata da numerosi ritiri a causa della pioggia) e si piazzò pure secondo in Canada e terzo negli Stati Uniti. Si trovò così a metà stagione in buona posizione in classifica generale, salvo poi incappare in una serie di ritiri che lo riportarono distante dalla vetta. Una seconda vittoria la ottenne l’anno successivo in Sudafrica, mentre ben poco fortunato fu il momentaneo passaggio all’Alfa Romeo nel 1984 e 1985. La sorte cominciò finalmente a girare solo nel 1989, quando era ormai un veterano dei Gran Premi con più di dieci anni di esperienza alle spalle: la Williams, che l’aveva messo sotto contratto l’anno prima, trovò finalmente l’assetto giusto grazie al motore Renault e, dopo le poco proficue prime tre gare, proiettò il padovano in lotta per il titolo con quattro podi consecutivi e cinque in sei gare; purtroppo per l’italiano, però, il Mondiale si rivelò presto una gara a due tra Prost e Senna, entrambi alla McLaren Honda, col secondo più vincente ma il primo più continuo e campione alla fine della stagione. Patrese ci riprovò comunque di nuovo nel 1991 e nel 1992, ormai quasi quarantenne: nel primo caso vinse due Gran Premi ma non riuscì a tenere testa allo strapotere di Senna, piazzandosi terzo dietro al compagno di scuderia Mansell; l’anno dopo, con la McLaren in calo e la crescita non ancora completa della Benetton, la Williams finalmente ebbe l’occasione di vincere, ma tutte le innovazioni vennero date prima a Mansell, di fatto la prima guida, e Patrese non andò oltre il titolo di vicecampione del Mondo. L’ultima annata prima del ritiro, corsa con la Benetton, lo vide infine chiudere al quinto posto assoluto.
Leggi anche:
Elio De Angelis
Meno fortunata rispetto a quella di Patrese fu la carriera del quasi coetaneo Elio De Angelis, nato a Roma nel 1958 e purtroppo scomparso prima di poter raggiungere il traguardo dei trent’anni. Il suo percorso fu però, almeno all’inizio, simile a quello del compatriota di cui abbiamo appena finito di parlare: dopo essersi fatto le ossa nelle competizioni minori e aver conquistato nel 1977 il titolo di campione nazionale di Formula 3, approdò in Formula 1 sempre grazie alla Shadow, costantemente alla ricerca di nuovi talenti da lanciare nel panorama dell’automobilismo mondiale; già dal suo primo anno mise in mostra promettenti qualità, passando poi nel 1980 alla Lotus e ottenendo il suo primo podio in Brasile, alla seconda gara con la nuova scuderia. I primi anni alla casa britannica – con l’eccezione dell’annata nera 1983, in cui riuscì a concludere solo due GP – furono caratterizzati da buoni piazzamenti, coronati dalla vittoria del Gran Premio d’Austria nel 1982 (in un fotofinish memorabile con il finlandese Keke Rosberg, all’interno di una gara comunque caratterizzata da molti ritiri); ma dal 1984 De Angelis sembrò in grado di poter correre per le prime posizioni, visto che era maturato lui come pilota ed era cresciuta anche la sua vettura. Il 1984 infatti partì molto bene, col pilota italiano capace di conquistare subito la pole position nella prima prova in Brasile, poi conclusa al terzo posto; fino a metà campionato De Angelis continuò ad accumulare punti, salendo sul podio anche a Imola e nei due GP statunitensi di Detroit e Dallas, ma nella seconda parte della stagione la superiorità tecnica della McLaren emerse in maniera indiscutibile, soprattutto per la capacità dei tecnici della Porsche di gestire meglio le limitazioni al carburante imposte da regolamento in quella stagione. De Angelis concluse comunque terzo assoluto, anche se molto staccato da Lauda e Prost, che si contesero il titolo fino all’ultimo giro dell’ultima corsa. L’anno dopo l’inizio fu ancora incoraggiante, con la vittoria a Imola, tanti piazzamenti tra i primi cinque e un momentaneo primo posto nella classifica generale, ma lo strapotere di Prost e della sua McLaren furono ancora una volta troppo netti per tutti. Nel 1986 De Angelis cambiò quindi scuderia, passando alla Brabham, dove trovò anche Patrese; la macchina però non riuscì ad ingranare e non si dimostrò nemmeno troppo sicura: durante una sessione di prove private a Marsiglia infatti si staccò l’alettone posteriore dell’auto, facendo cappottare più volte l’auto, che prese pure fuoco: gli insufficienti mezzi di soccorso e l’arrivo tardivo dell’elicottero condannarono De Angelis a non salvarsi. La sua morte fece scalpore e destò commozione, oltre a spingere i piloti a minacciare la FIA di sciopero se non si fossero migliorate immediatamente le condizioni di sicurezza delle piste e delle prove. De Angelis, assieme al Michele Alboreto di cui parleremo subito, era in quel momento la miglior promessa dell’automobilismo italiano, come non se ne vedevano da anni.
Michele Alboreto
Coetaneo di De Angelis era anche l’altra grande promessa della Formula 1 di quegli anni, quel Michele Alboreto che fu l’ultimo pilota italiano a vincere una gara di Formula 1 a bordo di una Ferrari, e quello che andò più vicino a un titolo di Campione del Mondo che manca ai nostri concittadini dai tempi proprio di Ascari, il pilota a cui più spesso Alboreto è stato paragonato per stile di guida. Nato a Milano nel 1956, aveva seguito un cursus honorum simile a quello di Patrese e De Angelis, passando dalle formule minori – ma anche correndo in endurance, a volte in coppia proprio con Patrese – prima di approdare nella categoria principale nel 1981 grazie alla Tyrrell, che comunque non passava un buon momento. Già dal 1982, comunque, cominciò a mettersi in mostra, soprattutto nell’ultima gara di Las Vegas, in un circuito a lui congeniale che gli permise di ottenere il terzo posto in qualifica e poi superare Prost durante la corsa, aggiudicandosi la gara; il buon risultato fu poi ripetuto anche l’anno seguente, quando Alboreto portò la sua Tyrrell a vincere a Detroit, approfittando del ritiro di Arnoux e di una tattica di gara molto accorta. Questi buoni risultati conquistati a 26 e 27 anni d’età gli permisero di stuzzicare l’interesse della Ferrari: fu ingaggiato nel 1984, ma la prima stagione – nonostante la vittoria con pole in Belgio e i due secondi posti a Monza e al Nürburgring – fu nel complesso deludente, con la McLaren dominatrice e Alboreto superato alla fine in classifica generale anche da De Angelis, alla guida della Lotus. L’anno giusto sarebbe dovuto essere, però, il 1985, visto che la Ferrari sembrava in grado di colmare il gap rispetto alla casa automobilistica rivale: la partenza del campionato fu infatti incoraggiante, con Alboreto vincente in Canada e soprattutto sul podio in otto delle prime dieci gare, tanto da diventare il primo pilota italiano a guidare la classifica generale dai tempi del 1958. Anche la seconda parte di stagione si aprì benissimo, con una vittoria in Germania ottenuta rimontando addirittura dall’ottavo posto, ma quello fu probabilmente il canto del cigno del pilota italiano e della sua Ferrari: nella quintultima prova, a Monza, chiuse solo tredicesimo e nelle ultime quattro gare dovette sempre ritirarsi a causa dell’introduzione di un nuovo motore non affidabile quanto il precedente, lasciando di fatto via libera a Prost, che andò a conquistare il titolo. Le tre stagioni successive, tutte affrontate alla guida della Ferrari, furono deludenti soprattutto per problemi di prestazione della monoposto, che non riuscì a risultare competitiva, tanto è vero che la casa di Maranello scese spesso e volentieri al quarto posto nel Mondiale costruttori, sopravanzata da Williams, McLaren e Lotus. L’addio con la Ferrari si consumò così nel 1988, con Alboreto costretto a trovarsi una nuova squadra e a firmare prima per la Tyrrell e poi per la Arrows, con vetture che però non erano per nulla competitive e non gli permettevano di correre neppure per la zona punti. Ritiratosi nel 1994 – dopo due stagioni incolori alla Scuderia Italia e alla Minardi -, si spostò a correre gare a ruote coperte, sia nel campionato DTM che in altre manifestazioni prestigiose come la 24 Ore di Le Mans; fu proprio mentre si preparava a una nuova edizione di quella corsa, nel 2001, che morì mentre stava effettuando dei collaudi sulla sua Audi a causa di un pneumatico forato e di un successivo schianto con capovolgimento della vettura, a tal proposito: L’incidente e la morte del grande Michele Alboreto
Leggi anche:
Lo staff di Medicina OnLine
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere aggiornato sui nostri nuovi post, metti like alla nostra pagina Facebook o seguici su Twitter, su Instagram o su Pinterest, grazie!
Condividi questo articolo:
 La vita di Janet Frame è una bellissima storia di rinascita, che in pochi conoscono, ma che merita di essere ricordata. Due volte è stata proposta per il premio Nobel, è la scrittrice neozelandese più nota insieme a Katherine Mansfield. In Italia non la stampiamo e non la leggiamo più, chi l’ha letta e amata continua ad amarla, ma le nuove generazioni non avranno questa grande occasione.
La vita di Janet Frame è una bellissima storia di rinascita, che in pochi conoscono, ma che merita di essere ricordata. Due volte è stata proposta per il premio Nobel, è la scrittrice neozelandese più nota insieme a Katherine Mansfield. In Italia non la stampiamo e non la leggiamo più, chi l’ha letta e amata continua ad amarla, ma le nuove generazioni non avranno questa grande occasione.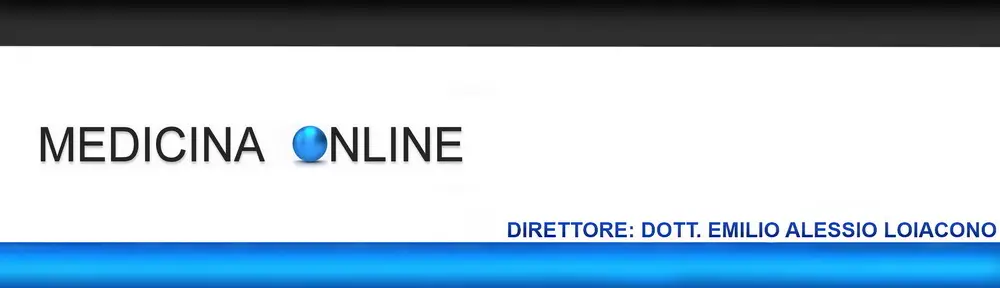











 Il famoso bodybuilder statunitense Dallas McCarver è purtroppo deceduto ieri, 22 agosto 2017, secondo alcune fonti in seguito a soffocamento durante l’ingestione di cibo, mentre altre fonti non ufficiali parlano invece di infarto del miocardio improvviso.
Il famoso bodybuilder statunitense Dallas McCarver è purtroppo deceduto ieri, 22 agosto 2017, secondo alcune fonti in seguito a soffocamento durante l’ingestione di cibo, mentre altre fonti non ufficiali parlano invece di infarto del miocardio improvviso.






 Siamo abituati a pensare agli eroi come a uomini straordinari, dotati di poteri speciali e di capacità sovrumane. Ma gli eroi sono altri, sono le persone normali che fanno ogni giorno il proprio dovere.
Siamo abituati a pensare agli eroi come a uomini straordinari, dotati di poteri speciali e di capacità sovrumane. Ma gli eroi sono altri, sono le persone normali che fanno ogni giorno il proprio dovere. Il grande nuotatore statunitense Michael Phelps nasce a Baltimora (Maryland, USA) il giorno 30 giugno 1985. E’ l’atleta più titolato nella storia delle Olimpiadi moderne: con 23 medaglie d’oro è l’olimpionico più vincente (davanti a Larisa Latynina, detentrice anche del precedente primato di podi, 18, Paavo Nurmi, Mark Spitz e Carl Lewis, che ne hanno vinte 9); agli ori si aggiungono tre medaglie d’argento e due di bronzo, per un totale di 28 podi. Delle 23 vittorie, 13 sono individuali (un record) e 10 in staffetta; dei 28 podi, 16 sono individuali (altro record, davanti ai 14 di Larisa Latynina). Conquistando otto ori a Pechino 2008 ha raggiunto il più alto numero di medaglie d’oro vinte da un atleta in una singola edizione dei Giochi olimpici, superando il primato di sette ori vinti da Mark Spitz a Monaco di Baviera 1972; quattro anni prima, ad Atene 2004, aveva mancato questo record fermandosi a sei ori e due bronzi.
Il grande nuotatore statunitense Michael Phelps nasce a Baltimora (Maryland, USA) il giorno 30 giugno 1985. E’ l’atleta più titolato nella storia delle Olimpiadi moderne: con 23 medaglie d’oro è l’olimpionico più vincente (davanti a Larisa Latynina, detentrice anche del precedente primato di podi, 18, Paavo Nurmi, Mark Spitz e Carl Lewis, che ne hanno vinte 9); agli ori si aggiungono tre medaglie d’argento e due di bronzo, per un totale di 28 podi. Delle 23 vittorie, 13 sono individuali (un record) e 10 in staffetta; dei 28 podi, 16 sono individuali (altro record, davanti ai 14 di Larisa Latynina). Conquistando otto ori a Pechino 2008 ha raggiunto il più alto numero di medaglie d’oro vinte da un atleta in una singola edizione dei Giochi olimpici, superando il primato di sette ori vinti da Mark Spitz a Monaco di Baviera 1972; quattro anni prima, ad Atene 2004, aveva mancato questo record fermandosi a sei ori e due bronzi. Il mio mito è Django Reinhardt. Django Reinhardt nacque a Liberchies, una città del Belgio, il 23 gennaio del 1910 da una famiglia di etnia sinti, che girovagava in varie nazioni europee e nord-africane, fino a stabilirsi a Parigi. Ancora giovanissimo, Django era già un apprezzato suonatore di banjo, ma la sua vita era destinata a cambiare per sempre. Quando aveva appena diciotto anni la roulotte di famiglia dove lui viveva, fu infatti divorata da un incendio: Django riportò gravi ustioni, tanto da perdere l’uso della gamba destra e di buona parte della mano sinistra, cioè quella che usava sulla tastiera del proprio strumento musicale. L’anulare e il mignolo, distrutti dal fuoco, furono saldati insieme dalla cicatrizzazione e divennero inutilizzabili. Subito dopo l’incendio del caravan, Django rifiutò fermamente l’amputazione della mano sinistra e del piede destro e riuscì fortunosamente a superare il rischio di cancrena che gli si prospettava, ma per lui ogni aspirazione di essere musicista, era ormai del tutto svanita.
Il mio mito è Django Reinhardt. Django Reinhardt nacque a Liberchies, una città del Belgio, il 23 gennaio del 1910 da una famiglia di etnia sinti, che girovagava in varie nazioni europee e nord-africane, fino a stabilirsi a Parigi. Ancora giovanissimo, Django era già un apprezzato suonatore di banjo, ma la sua vita era destinata a cambiare per sempre. Quando aveva appena diciotto anni la roulotte di famiglia dove lui viveva, fu infatti divorata da un incendio: Django riportò gravi ustioni, tanto da perdere l’uso della gamba destra e di buona parte della mano sinistra, cioè quella che usava sulla tastiera del proprio strumento musicale. L’anulare e il mignolo, distrutti dal fuoco, furono saldati insieme dalla cicatrizzazione e divennero inutilizzabili. Subito dopo l’incendio del caravan, Django rifiutò fermamente l’amputazione della mano sinistra e del piede destro e riuscì fortunosamente a superare il rischio di cancrena che gli si prospettava, ma per lui ogni aspirazione di essere musicista, era ormai del tutto svanita. Il mio mito è Alan Turing. Alan Mathison Turing nacque a Londra 23 giugno 1912. Da studente era decisamente poco appassionato a materie come la letteratura, il latino e la religione: ad esse preferiva letture riguardanti la Teoria della Relatività, i calcoli astronomici, la chimica o il gioco degli scacchi. Nel 1931 fu ammesso al King’s College dell’Università di Cambridge dove fu allievo di Ludwig Wittgenstein e dove approfondì i suoi studi sulla meccanica quantistica, la logica e la teoria della probabilità (dimostrò autonomamente il teorema centrale del limite, già dimostrato nel 1922 dal matematico Lindeberg).
Il mio mito è Alan Turing. Alan Mathison Turing nacque a Londra 23 giugno 1912. Da studente era decisamente poco appassionato a materie come la letteratura, il latino e la religione: ad esse preferiva letture riguardanti la Teoria della Relatività, i calcoli astronomici, la chimica o il gioco degli scacchi. Nel 1931 fu ammesso al King’s College dell’Università di Cambridge dove fu allievo di Ludwig Wittgenstein e dove approfondì i suoi studi sulla meccanica quantistica, la logica e la teoria della probabilità (dimostrò autonomamente il teorema centrale del limite, già dimostrato nel 1922 dal matematico Lindeberg).